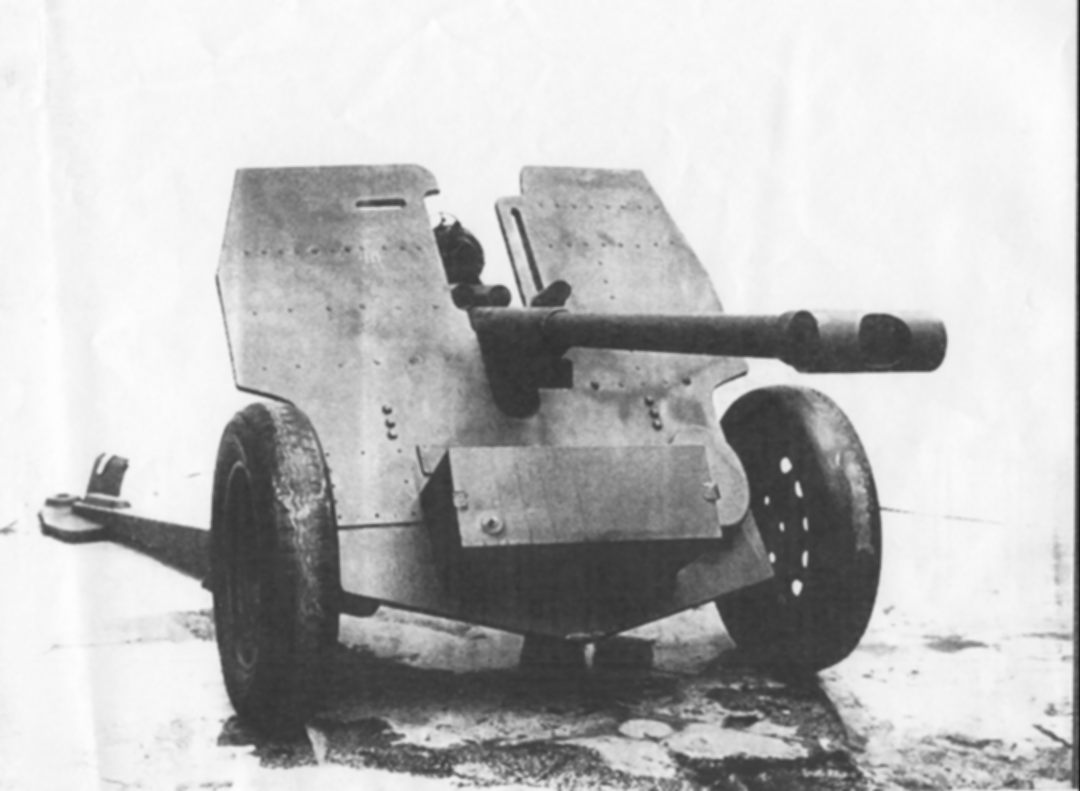
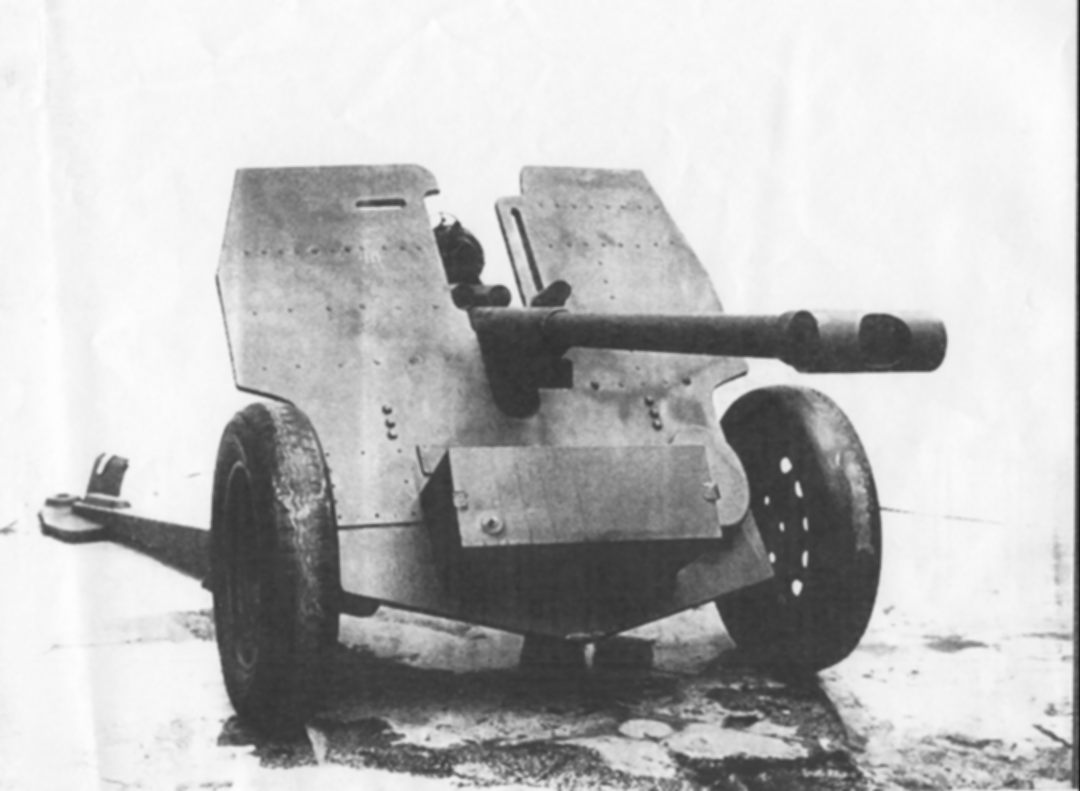
Dedicato a Carlo, senza retorica.
Cercando di far coesistere le ragioni del cuore e quelle della mente. Come dovrebbe fare chiunque si dichiari in rotta di collisione con questo presente. Cercando, inoltre, di superare l'enfasi dei discorsi di questi giorni di questi giorni. Troppe volte, infatti, abbiamo sentito frasi tipo "e' morto un partigiano ne nascono altri cento". E troppe volte, ancora, ci siamo confrontati con allarmismi su scenari di tipo cileno. Pesano, certo, le nostre contraddizioni, i limiti che abbiamo rivelato nel dibattito che ha preceduto il G8. Un dibattito eccessivamente legato alla questione dei comportamenti di piazza. Un dibattito che troppo ha concesso a quei nuovismi terminologici che cercano di coprire il vuoto concettuale. Si pensi, in tal senso, alla parola piu' usata in questi mesi: "impero". Dove risiede la sua superiorita' rispetto al concetto di imperialismo? Se abbandoniamo il campo dell'affabulazione pura che e' ormai il diletto principale di Toni Negri e dei suoi seguaci, ci rendiamo conto di quanto tale nuova definizione sia inutile persino sul piano meramente descrittivo. Non c'e' niente da fare. Dopo Genova, con tutto quello che ha significato, deve subentrare lo sforzo analitico. L'emozionalita' di chi e' stato colpito dalla macchina repressiva dello Stato deve sospingere la ragione, l'azione di indagine e di comprensione dei fatti.
Cos'e' successo a Genova, perche' vi e' stato un cosi' cruento attacco verso chiunque esprimesse un dissenso rispetto all'esistente? E' impossibile rispondere a tale domanda senza riconoscere, prima, un limite culturale e teorico.
Poche strutture, negli ultimi anni, si sono occupate delle problematiche relative ai nuovi assetti istituzionali, alla divisione dei compiti tra lo Stato e gli organismi sovranazionali. I contributi che, in tal senso, hanno offerto riviste come "La Contraddizione", "Vis-a-vis, Quaderni per l'autonomia di classe" e lo sforzo compiuto in questa direzione dal Collettivo Politico Antagonista Universitario, sono rimasti isolati. Cosi', in preda alle mode del momento, si e' parlato spesso di uno Stato ormai deprivato di qualsiasi funzione. Sbagliando, dimostrando di avere una conoscenza superficiale delle teorie degli stessi nuovisti. Per capirci meglio: a suo tempo Marco Revelli aveva ricordato che la sovranita' (cioe' la pienezza del potere dello Stato) consiste nel contemporaneo possesso del "monopolio della decisione" definito da Carl Schmitt e del "monopolio dell'uso legittimo della forza" analizzato da Max Weber. Ora, sul fatto che il primo stia venendo meno non vi possono essere dubbi. Gli sviluppi impetuosi della "internazionalizzazione reale" del capitale solo in parte possono essere ricondotti al controllo, all'intervento regolatore, alla decisionalita' (appunto) dello Stato. Sul secondo elemento costituente la sovranita', invece, la discussione e' ancora aperta.
Anzi, Genova in particolare contribuisce a riaprirla. E se ne sono accorti anche alcuni nuovisti. Tra questi, Marco D'Eramo, che in un articolo pubblicato su "Il Manifesto" del 24 luglio 2001 ("Pallottole di Stato"), oltre a prendersela con le anime belle della sinistra stupite dal comportamento della polizia (si pensi a Bertinotti), pone questioni di assoluto rilievo. Sostiene D'Eramo: "Ci eravamo dimenticati della violenza di Stato e delle brutalita' poliziesche. Quasi quasi, prima di vederli in tenuta antisommossa, li avevamo perfino presi per una specie di servizio sociale. Ci era sfuggito che la definizione funzionale delle forze di polizia di uno Stato e' quella di 'apparato repressivo' e che -in accordo con Max Weber- cioo' che fa dello Stato uno Stato e' il 'detenere il monopolio della violenza' (legittima secondo Weber, ma anche illegittima quando e' il caso)". Certo, vi e' un errore concettuale, poiche' il legittimo di Weber non e' un giudizio di valore sull'operato dello Stato, ma l'indicazione del fatto che solo la violenza esercitata dallo stesso e' conforme all'ordinamento vigente, inteso non tanto nei suoi codici quanto nella sua intima essenza. Tuttavia, non ne risulta inficiata la sostanza del discorso di Marco D'Eramo, che anzi spinge a riflessioni piu' approfondite, che facciano ricorso in modo piu' immediato all'elaborazione di Max Weber.
Il sociologo tedesco, nelle sue considerazioni, muove dall'analisi del comportamento dello Stato nel vivo della prima guerra mondiale. Nel 1917, egli arriva a scrivere che allo Stato "viene oggi attribuita una forza 'legittima' sulla vita, la morte e la libertà".
Lo Stato, quindi, detiene il "monopolio della violenza sui corpi" dei cittadini, riservandosi di superare i limiti posti dal diritto al pieno dispiegarsi dell'attività repressiva, della soppressione del dissenso. La guerra, il prodursi di situazioni di conflitto sociale all'interno, tutti quei momenti che comportano misure restrittive nei confronti della liberta' di azione e di circolazione, non fanno che rivelare -qui sta il punto- l'autentica natura dei moderni stati capitalistici, che contengono in se', a livello embrionale, il principio del totalitarismo. A Genova, quindi, non si e' inaugurata nessuna linea sudamericana. Questo Stato ha rivelato la sua essenza di fronte al pericolo. Al pericolo rappresentato non tanto dal "popolo di Seattle", quanto dai possibili sviluppi del cosiddetto movimento antiglobalizzazione. Infatti, la contestazione contro il G8 ha visto la presenza -accanto all'associazionismo- delle componenti piu' avanzate di precisi segmenti della classe proletaria. Una loro maggiore internita' al movimento porterebbe ad un "salto di qualita'" dello stesso. Percio' lo Stato si e' accanito con tanta forza verso le mobilitazioni. E lo ha fatto sia per conto della borghesia italiana, ormai saldamente compatta attorno all'ipotesi di centrodestra, sia per conto del capitale internazionale. Lo si può dire senza tema di smentite, poiche' il mantenimento del monopolio della forza allo Stato non cozza con la sua perdita di decisionalita' su altri piani. E' il sistema capitalistico nel suo complesso, d'altra parte, ad avere ancora bisogno degli Stati, come momenti di organizzazione del consenso e di attuazione delle direttive degli organismi sovranazionali. Di piu', come garanti delle stesse di contro ad ogni opposizione interna.
Le giornate di Genova ce lo hanno ricordato.
Facciamone tesoro. Un movimento che parte dalla consapevolezza puo' costituire una forza invincibile. Una forza che, nel marciare verso i suoi obiettivi, riesca a volgere costantemente il suo sguardo al passato. Ascoltando la voce di Carlo e di tutti coloro che hanno lottato, anche solo per un giorno, contro questa societa' fatta di sfruttamento e di galere.