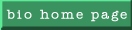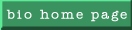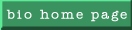ALIMENTAZIONE E BIOTECH.
Senza poi tanto clamore soprattutto dovuto a mancanza d'informazione le nostre tavole e quindi la nostra alimentazione, sono gia' invase da prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati.
Ossia quella che viene definita la rivoluzione biotecnologica applicata all'agricoltura e quindi un possibile passaggio epocale sulle forme di produzione ed alimentazione viene consumata sulla nostra, quasi sempre in modo inconsapevole, pelle senza che sia stata data una risposta positiva ed esauriente sulle reali conseguenze sulla vita di tutti gli esseri viventi.
Si potrebbe obiettare che la maggior parte di noi non e' a conoscenza delle conseguenze che l'uso di tante sostanze industriali (medicine, prodotti chimici ecc.) hanno di noi o sugli altri esseri, ed e' vero ma e' anche vero che tutte le sostanze di questo tipo presenti al mondo sono state testate, e' possibile conoscerne i risultati le loro conseguenze e controindicazioni, dando nei limiti del possibile la possibilita' di scelta se utilizzarle o no oppure di utilizzare cose e prodotti di cui si sappia se abbiano fatto uso delle sostanze in questione.
Cosi' ci dobbiamo fidare delle assicurazioni delle grandi multinazionali che hanno depositato i brevetti delle sostanze transgeniche e soprattutto ci dobbiamo sorbire tali sostanze, in molti casi a nostra insaputa.
Tutto questo si basa su un vuoto legislativo lasciato dai paesi occidentali che ancora oggi non ha saputo formulare delle direttive chiare sull'uso di sostanze transgeniche per dare quantomeno al consumatore la possibilita' di scegliere se desidera o meno di nutrirsi con cibi biotech.
La mancanza d'informazione non permette all'opinione pubblica di valutare correttamente la situazione in questo particolare campo fondamentale per la nostra sopravvivenza.
Si pensi solo che tra cibi trasformati e di origine animale, circa due terzi degli alimenti sono prodotti utilizzando soia, mais e loro derivati. Nel mondo il maggior produttore ed esportatore di soia e mais sono gli Usa, dove nel 1998 il 30% dei campi di soia e il 25% dei campi di mais sono stati piantati con sementi ingegnerizzate. Si tenga presente che gli Usa sono i maggiori produttori di mais nel mondo con piu' di 2 miliardi e 360 milioni di tonnellate; nel mondo se ne producono 5 miliardi e 800 milioni di tonnellate, in Italia quasi 97 milioni. Anche per quanto riguarda la soia gli Usa sono i maggiori produttori mondiali con 648 milioni di tonnellate prodotte rispetto a una produzione mondiale complessiva di 1 miliardo e 303 milioni di tonnellate (l'Italia ne produce quasi 8,5 milioni di tonnellate. Dall'entrata in funzione del primo brevetto transgenico, avvenuta in Cina nel 1992, secondo la Federazione Internazionale del Commercio delle Sementi (FIS) attualmente, nel mondo, gli ettari coperti da colture transgenetiche sono 29.4 milioni di ettari (nel 96 erano 2.9 milioni) con una previsione per il 1999 superiore ai 60 milioni. Le specie vegetali transegeniche piu' coltivate sono: soia (15 milioni di ettari), mais (8.2), colza (2.4), ortaggi (500.000), tabacco (100.000).
Il 64% delle colture transgeniche mondiali e' prodotto dagli Usa, il 15% dall'Argentina, il 10% dal Canada, il 5% dalla Cina, mentre l'Europa si mantiene al di sotto dell' 1%.
Leaders del settore sono le multinazionali Monsanto e Novartis. Le due si vantano che loro semi modificati sono in grado di resistere ad uno dei piu' potenti erbicidi in commercio, il Roundup Ready (prodotto dalla stessa Monsanto!) e al terribile parassita del mais, la piralide.
Laddove si riesca ad avere informazioni sull'uso delle sostanze modificate, questa e' gestita in esclusiva dalle multinazionali del settore, le quali non possono che tessere elogi su quella che definiscono la seconda rivoluzione agricola. La loro filosofia si puo' riassumere in cinque punti:
a) diventando le coltivazioni un processo prevalentemente industriale, si ottiene e si garantisce un maggiore controllo sugli alimenti attraverso un'azione preventiva contro la contaminazione di organismi patogeni e una di pianificazione con la programmazione delle caratteristiche volute per un maggior contenuto nutritivo e per una maggiore qualita'.
b) gli alimenti ottenuti da semi modificati hanno lo stesso sapore e lo stesso impatto sulla salute umana rispetto a quelli ottenuti da semi naturali. Il principio infatti e' quello degli incroci tra geni, principio simile a quello degli incroci tra piante in agricoltura.
c) i rischi ambientali sono nulli, anzi , producendo semi che originano piante resistenti a parassiti ed erbicidi, l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, diminuisce.
d) i semi trasformati, adattandosi alle piu' svariate situazioni del pianeta, possono essere una risposta importante al problema della fame del mondo.
e) le biotecnologie permettono anche di conservare e recuperare semi ed altri prodotti anche di natura animale, estintesi negli anni soprattutto in alcune aree del pianeta.
Tutto molto bello, se non fosse che questi buoni propositi e finalita' si basano su elementi non detti ma di grande gravita' per capire l'entita' reale del problema.
E' vero che in agricoltura si sono sempre incrociate tra di loro le piante ma e' pur sempre vero che gli incroci, anche strani, avvenivano con esseri appartenenti allo stesso regno, quello vegetale. Le biotecnologie hanno introdotto una terribile variante laddove si tende ad incrociare geni di regni naturali differenti, con l'introduzione di geni animali nella scala del DNA di quelli vegetali. Lo scopo e' semplice; il gene animale opportunamente scelto puo' svolgere un ruolo fondamentale nella lotta ai parassiti sia come inibitore sessuale e sia come deterrente letale. Allo stesso tempo pero' viste le differenze nelle successioni di geni tra esseri vegetali e d esseri animali, non si e' sicuri della esatta allocazione del gene e soprattutto non e' dato ancora sapere, dato il poco tempo di sperimentazione, quale possa essere il rilascio in termini di nocivita' e modificazioni genetiche relativamente alla produzione di proteine e tossine.
Non e' nemmeno chiara ma non meno preoccupante, la possibilita' che dietro la pressione selettiva propria della natura e la sua capacita' di adattamento a tutte le situazioni, i parassiti imparino a resistere ai geni modificati generando dei super-insetti indistruttibili. E allora ad ogni nuovo parassita si procedera' a una nuova modificazione genetica del seme fino a che questo correra' il rischio di avere ben poco di vegetale nel suo patrimonio naturale.
Inoltre la resistenza ai prodotti chimici di sintesi presenti in campo agricolo-alimentare (ironia della sorte prodotti dagli stessi fabbricanti di geni modificati) non rappresenta per niente una garanzia alla limitazione nell'uso di almeno queste sostanze nocive, anzi. Infatti produrre un seme resistente agli erbicidi, significa avere un seme che puo' essere tranquillamente bombardato da tali sostanze per eliminare radicalmente il problema delle erbe infestanti, aumentando la resa.
L'espansione del fenomeno delle piante transgeniche (vedi i dati sugli Usa) e l'eccessiva disinvoltura con cui vengono condotti i rilasci di piante modificate, non sufficientemente isolate dall'ambiente circostante, pone in serio pericolo la biodiversita' visto anche che e' scientificamente provato che i geni saltano da una pianta all'altra.
Anche il recupero di semi o prodotti di altra natura attraverso la manipolazione genetica esaurisce ben presto i suoi elementi positivi di recupero di varieta' naturali estinte laddove l'intervento umano non valuta correttamente i principi di selezione naturale che hanno portato alla sparizione di certe varieta' naturali e dove il brevetto apposto su questi tipi di ricerca rischia di diventare in ogni caso una ulteriore imposizione di origine prettamente commerciale.
Infine, nel buco di verifica sulle reali conseguenze derivanti dall'uso di organismi geneticamente modificati (ogm), e' impossibile sapere quale e' l'impatto sulla diffusione di nuove allergie e resistenza agli antibiotici derivante dall'uso dei cibi transgenici.
Il vuoto legislativo e la mancanza di coordinamento tra i paesi Cee, ha determinato una serie di conseguenze che ricadono direttamente sulla pelle dei consumatori.
Come prima cosa si verifica che al momento non e' possibile stabilire con esattezza dove e quanto i depositi di semi e i magazzini di prodotti da loro derivanti, siano contaminati da organismi modificati. E' praticamente impossibile stabilire l'origine modificata di miliardi di tonnellate di sostanze in quanto non sussistendo fino ad adesso l'obbligatorieta' di segnalare un prodotto modificato all'origine e non esistendo nemmeno regole di trasporto differenziato tra semi naturali e quelli modificati, non si e' praticamente in grado di certificare, con assoluta certezza, un prodotto non modificato geneticamente.
Esistono tecniche per stabilire se un seme e' modificato geneticamente, legate all'analisi della reazione a catena della polimerasi che consiste in un'analisi della mappature del DNA, ma applicato a larga scala prevede dei costi e tempi d'attuazione non proponibili. Per non parlare dei derivati di sostanze modificate dove l'analisi e' praticamente impossibile.
Visto tale quadro, alcune catene distributivi hanno cominciato gia' a mettere le mani avanti. Tra queste la Coop che si appresta a proporre i propri alimenti con etichette indicanti, laddove possibile anche se responsabili della lega Coop affermano che la contaminazione delle stive delle navi e dei mulini e' gia' un'amara realta', la percentuale di vegetale modificato presente nel prodotto. Nel caso in cui non fosse possibile stabilire tale dato, l'etichetta apportera' la dicitura che l'alimento non e' esente da manipolazione genetica. Allo stesso modo la Nesle' si appresta ad indicare sui prodotti derivanti dalla soia, che questi hanno una buona probabilita' di contenere materiale geneticamente modificato.
Il caos regna anche a livello politico; infatti ci sono paesi come l'Austria e il Lussemburgo che hanno bandito i prodotti modificati, laddove riescano ad identificarli, e di fatto impediscono la circolazione di merci sospette sul proprio territorio, violando il principio della libera circolazione delle merci della Comunita' Europea. In Francia il Consiglio di Stato ha sospeso la coproduzione e commercializzazione del mais transgenico della Novartis, mentre in Gran Bretagna il ministro dell'ambiente ha proposto una moratoria di tre anni su queste coltivazioni.
In Danimarca l'industria ha sottoscritto un accordo volontario per non produrre ne' commercializzare prodotti Ogm nel 99; la Grecia invece appellandosi alla clausola di garanzia della Commissione europea ha bloccato per tre mesi l'importazione di una varieta' di colza modificata.
L'Italia , cosi' come gia' fatto dall'Olanda e dopo un lungo travaglio politico, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Giustizia Europea, alla Direttiva della stessa Comunita' (direttiva Ce 98/44), sulla protezione giuridica dei brevetti, che tenderebbe a colpire il motore economico del fenomeno biotech, in attesa di trovare una posizione comune interna e in seno alla Cee sulla ricerca e utilizzazione delle invenzioni biotecnologiche. Questi ricorsi si basano sul principio che la direttiva, di fatto, permette di brevettare materie biologiche, ossia materie vive e capaci di riprodursi, creando quindi dei diritti di proprieta' industriale su sostanze che fino ad oggi non erano comprese nel campo di beni brevettabili, determinando una controversia giuridica molto grave, avvalorata poi dalla mancanza di una sperimentazione seria sulle conseguenze dell'utilizzo di tali brevetti sugli esseri viventi .
Un primo tentativo valido di regolamentare questo importante settore viene da un'altra Direttiva europea che andra' a sostituire quella del 1990 (90/220) proposta al Parlamento Europeo il 26 febbraio del 1998, modificata ed approvata dall'ultimo Consiglio ambiente del 21 dicembre e in via di approvazione definitiva da parte del Parlamento.
Scopo della direttiva e' quello d'imporre criteri piu' precisi e rigorosi per l'etichettatura e per la valutazione del rischio ambientale e sanitario dei prodotti transgenici.
Sei sono gli elementi importanti del provvedimento:
1) Autorizzazioni. Le autorizzazioni all'utilizzo di Ogm avranno una scadenza temporale precisa dopo la quale dovranno essere rinnovate. La commissione Ue incaricata aveva proposto 7 anni che quasi sicuramente arriveranno a 12. Le autorizzazioni in vigore prima della nuova direttiva avranno una scadenza di 4 anni mentre quelle richieste, con la vecchia normativa, ma non ancora approvate scadranno dopo 6 anni.
2) Comitati tecnici e etici. La direttiva prevede la possibilita' e forse l'obbligo, ancora non e' chiaro, di consultare comitati etici nazionali e comunitari, prima di rilasciare nuove autorizzazioni. Per quanto riguarda i comitati tecnici, in cui sono rappresentati tutti gli stati membri, ai poteri decisionali si aggiunge quello di poter respingere le proposte della Commissione Ue, con votazione a maggioranza semplice.
3) Etichettatura. Il consumatore dovra' obbligatoriamente essere informato della presenza di Ogm nei prodotti. Unica eccezione sara' nei casi in cui si verifica una sola presenza residuale (impurita' non intenzionali e tecnicamente inevitabili), pari ad una soglia minima da determinare caso per caso.
4) Rischi. Sono previste disposizioni molto rigorose sulla valutazione rischi nell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di Ogm. Quindi andra' segnalata ogni anomalia quale ad esempio la comparsa di insetti resistenti alle tossine contenute negli Ogm o di piante estranee resistenti agli erbicidi cui gli Ogm sono tolleranti.
5) Consultazioni pubbliche. Attraverso non meglio precisate campagne di sensibilizzazione, il testo prevede la consultazione obbligatoria del pubblico nel maggior parte dei casi di sperimentazione.
6) Legislazione verticale. Qualsiasi passaggio nella lavorazione industriale dovra' prevedere i requisiti di controllo, salvaguardia, monitoraggio, informazione, dei punti precedenti.
In vista della approvazione della nuova direttiva, i verdi europei hanno chiesto alla Commissione ambiente del Parlamento Europeo di imporre una moratoria di un anno sulle coltivazioni e commercializzazione di prodotti transgenici. Inoltre propongono un maggiore rigore per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti, affinche' questi siano dotati di un vero e proprio passaporto in cui siano elencati e identificabili, tutti i passaggi produttivi, di stoccaggio e distribuzione. Un etichetta di processo, gia' in vigore negli Usa e Canada, dove chiunque utilizza varianti modificate geneticamente, deve stipulare un vero e proprio contratto con l'azienda depositaria del brevetto cosi' che il prodotto derivante sara' sempre identificabile a qualsiasi livello di lavorazione.
Per quanto riguarda piu' specificatamente l'Italia, dovrebbe essere ormai scontata da parte del Governo di appellarsi, cosi' come fatto dall'Olanda, alla Corte di Giustizia europea, contro la direttiva europea sulla commercializzazione di ogm .
L'accordo su tale iniziativa esiste gia' tra i vari ministeri interessati (Ambiente, Industria, Sanita', Giustizia, Politiche Agricole) e si aspettano solamente le conclusioni della Convezione internazionale sulle biodiversita' in programma per la fine di febbraio, per procedere al ricorso.
In Italia la presenza di ogm e' limitata in genere a coltivazioni condotte a livello sperimentale (per i prodotti finiti come abbiamo gia' visto, attualmente, e' impossibile sapere con esattezza quanti e quali prodotti modificati entrano in Europa,
La sperimentazione autorizzate hanno interessato alcune varianti transgeniche di mais, barbabietole, patate, pomodori, radicchio, soia e tabacco. I brevetti relativi a tali sperimentazione sono di proprieta' delle grandi multinazionali chimiche quali Monsanto, Novartis e Pioneer. Le modificazioni introdotte servono ad ottenere migliore resistenza ai parassiti, erbicidi, malattie, per rallentare la marcescenza o per sincronizzare la maturazione per la raccolta meccanizzata.
Le ricerche vengono svolte in aziende private ma anche in centri di studio come quelli per la Cerealicoltura di Bergamo o Vicenza e l'Istituto di Genetica e Sperimentazione agraria di Genova.
Anche se la normativa che regola le coltivazioni sperimentali e' molto rigida per garantire l'isolamento di tali tipi di coltivazioni dall'ambiente circostante (area di rilascio recintata, sorvegliata, delimitata, segnalata e con presenza di barriere anti polline e trattamento delle acque reflue) tali procedure non vengono totalmente rispettate soprattutto nel caso di sperimentazioni private. E' il caso delle coltivazioni della Monsanto di Maccarese in provincia di Roma e dei campi semina segnalati alle rispettive Procure in provincia di Venezia e Piacenza.
Per concludere la rassegna nazionale di invasione di prodotti modificati, una recente inchiesta della rivista Altroconsumo, svolta in molti negozi su una scelta di 42 prodotti, ne ha scoperti alcuni contenenti sostanze modificate. Sono stati una Lecitinia di soia della ditta Valsoia, una crema di verdure liofilizzata per bambini della ditta Milupa, e due bistecche di soia delle ditte Ki e Fior di loto. Il sistema di analisi utilizzato e' stato quello della polimerizzazione a catena attraverso il quale sono stati scoperti il mais Maximiser di Novartis (resistente ad un insetto e a un diserbante) e la soia Round Up della Monsanto (resistente a un diserbante).